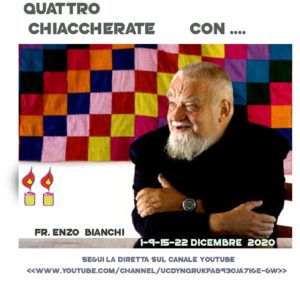Come spesso accade “nessuno è profeta in patria” la prossima assemblea regionale del veneto la facciamo a Piazzola Sul Brenta e ai più questa località ricorda la famosa villa Contarini, ma pochi sanno che oggi è famosa perchè è qui che ha preso i natali Giuseppe Criconia, che con Maria Teresa prima donna sposata ad essere presidente delle donne di Aziona Cattolica si distinsero nel primo dopoguerra per aver dato vita a quella realtà famigliare che va sotto il nome della COMUNITA’ del PORCELLINO, erano loro infatti che accolsero in casa La Pira, Lazzati, Dossetti, Fanfani, dove si costruirono le basi della nostra COSTITUZIONE, i loro figli tutti passati attraverso l’esperienza scout sono stati più volte a Piazzola per ricordare il padre, io sono fermamente convinto che la missione dell’A.S. sia anche di conservare la memoria, non in modo piagnucoloso, ma in modo che le generazioni possano capire che il passato apre la strada al futuro.
-Vi propongo l’articolo apparso sull’Osservatore Romano all’indomani della morte di Giuseppe la Moglie Maria Teresa è ancora viva.. a Roma … Un abbraccio Albert
[huge_it_slider id=”4″]
Comunità del Porcellino


Il nome della Comunità del Porcellino, oltre a far sorridere, dirà poco o nulla al lettore. Viene a rammentarlo la figura di Giuseppe Criconia, morto il 1° gennaio 2008 a Roma, i cui funerali si sono celebrati giovedì mattina nella parrocchia di Santa Paola. Con lui muore uno degli ultimi esponenti di quel singolare “sodalizio di convivenza” – sorto per necessità puramente logistiche presso la storica parrocchia romana di Santa Maria in Vallicella: la Chiesa Nuova – che, nel clima della Costituente, vide riuniti a Roma personaggi come Giorgio La Pira, Giuseppe Lazzati, Giuseppe Dossetti, Amintore Fanfani, Laura Bianchini, Angela Gotelli. Un sodalizio davvero curioso che Criconia, pur essendo il meno conosciuto – come egli stesso teneva a ricordare qualche anno fa – aveva contribuito in modo determinante, benché casuale, a riunire. Egli stesso, del resto, è stato a tutti gli effetti un modello esemplare di quel laicato cattolico che, tra la fine della seconda guerra mondiale e gli anni della ricostruzione, tanto ha dato al proprio paese in fatto di onestà, di discrezione, di nettezza morale, di disinteressato servizio: fatto di mezzi poveri; di umiltà; di rigore; di competenza professionale. Per anni Criconia operò nell’Azione Cattolica anche come presidente del gruppo romano dei laureati. E anche più tardi, negli anni successivi alla pensione, si sarebbe dedicato attivamente al volontariato accanto agli ammalati – in modo specifico agli infermi di mente – agli albori della Caritas romana, a fianco di don Luigi Di Liegro. La sua vicenda umana e cristiana lo avrebbe messo a contatto, e in amicizia, con personaggi di primo piano nella storia della repubblica italiana e del movimento cattolico, ma non di minore entità fu la sua personale testimonianza operosa di laico, di padre di famiglia, di professionista. Una testimonianza vissuta silenziosamente “dietro le quinte”, pur con tutti i suoi risvolti particolari. Nato a Piazzola sul Brenta (Padova) nel 1916, Giuseppe Criconia aveva studiato a Venezia e presso l’Università di Ca’ Foscari conseguì la laurea in Scienze Economiche sotto la guida di Ezio Vanoni. Il maestro, colpito dalla serietà dell’allievo, ne favorì l’assunzione all’Iri di Roma nel novembre del 1939. Come ricorda lo stesso Criconia in una memoria di qualche anno fa, la sua vita professionale si sarebbe svolta interamente nella capitale, salvo il triennio 1943-1946 quando l’Iri, dopo l’8 settembre, fu trasferito a Milano. Qui, nel capoluogo lombardo, il giovane veneto ebbe contatti nella clandestinità con i dirigenti della democrazia cristiana per l’alta Italia e partecipò attivamente alla Resistenza. Fu ospite del centro di assistenza sociale “La casa” organizzato dal sacerdote di Augusta (Siracusa) don Paolo Liggeri (1911-1996). Iniziativa sorta per aiutare quanti avessero avuta distrutta la loro abitazione dalla guerra, “La casa” in realtà offriva ospitalità anche a perseguitati politici e razziali e, in collegamento con la Radio Vaticana, registrava e inoltrava messaggi ai familiari dei militari prigionieri o dispersi. Secondo fonti dell’Anpi si calcola che da “La casa” siano stati trasmessi – antenna della trasmittente clandestina era un filo pendente da un parafulmine – oltre 172.000 messaggi. Anche Criconia fu sorpreso dall’irruzione che i nazifascisti operarono il 24 marzo 1944 nello stabile di via Mercalli. Quel giorno don Liggeri fu arrestato e in seguito deportato in Germania – sarebbe stato ritrovato e liberato dagli americani il 29 aprile 1945 dal lager di Dachau. Criconia invece scampò miracolosamente all’arresto per una circostanza singolare. Aveva diversi fogli di stampa clandestina nella scrivania e, ormai rassegnato al peggio, rimase muto e sbalordito che, all’atto della perquisizione, il suo cassetto fosse stato aperto e, quasi subito, bruscamente richiuso; senza conseguenze. Rientrato in stanza a pericolo passato, Criconia riaprì il cassetto e si accorse che la sua penna stilografica d’oro era sparita. Respirò. Non tutto il male viene per nuocere. Se l’occasione talvolta fa l’uomo ladro, l’avidità lo rende sempre cieco. Fu dunque a Milano che Criconia conobbe l’impetuosa bresciana Laura Bianchini (1903-1983), docente di filosofia e pubblicista, partigiana e deputata – alla I legislatura e in seguito insegnante di storia e filosofia al liceo “Virgilio” di Roma dal 1953 al 1973. Allo stesso periodo risale l’incontro con i cosiddetti “professorini” dell’Università Cattolica del Sacro Cuore: Fanfani, Dossetti, Lazzati. Quando questi amici si trasferirono a Roma, riuniti da Dossetti – che nel luglio 1946, essendo stato eletto vicepresidente della democrazia cristiana, aveva chiesto aiuto per l’impostazione e la realizzazione dei suoi nuovi impegni – per tutti ci furono notevoli difficoltà di natura logistica. Dispersi in punti diversi della città, c’era bisogno di incontrarsi per discutere – il che per forza di cose doveva avvenire, spesso, di sera – e per spostarsi da un luogo all’altro si dovevano superare non pochi disagi. A volte talune case di amici comuni, più facilmente raggiungibili da tutti, dovettero essere elette a punto di ritrovo: è ad esempio il caso dell’abitazione dell’economista Serafino Majerotto (1908-1995), trentino di Caldonazzo, anch’egli laureato alla “Cattolica” e impiegato in Vaticano all’ufficio studi dell’amministrazione speciale della Santa Sede. Majerotto abitò per alcuni anni a via Morin, una traversa di via della Giuliana, ad un passo da San Pietro, e la sua abitazione fu per diverso tempo punto d’incontro e di discussioni dei “professorini” e dei loro amici. Un giorno Criconia, essendo andato a trovare la Bianchini nella sua abitazione di via della Chiesa Nuova, 14, ove l’insegnante bresciana era ospite con Angela Gotelli, presso le sorelle Pia e Laura Portoghesi, grazie alla mediazione determinante del parroco della Chiesa Nuova, l’oratoriano padre Paolo Caresana, venne a sapere che i proprietari del II piano del palazzo si sarebbero trasferiti. Era perciò possibile prenderlo in affitto. Criconia prese rapidamente contatto col proprietario. Un detto e un fatto. Regolate le formalità cinque nuovi inquilini si stabilirono nell’appartamento: erano Fanfani, Dossetti, Lazzati, Giuseppe Glisenti e Criconia. Racconta uno dei nipoti delle sorelle Portoghesi, Telemaco Tuzi, che Criconia, in procinto di sposarsi, chiese e ottenne che gli fosse lasciata la stanza più grande dove voleva sistemarsi con la moglie in attesa di una soluzione definitiva; quella stessa stanza, prima del matrimonio di Criconia, di comune accordo fu utilizzata da Fanfani allorché questi, nominato ministro del Lavoro, si trasferì a Roma con la famiglia. Intanto su insistenza della Bianchini, una delle padrone di casa Laura Portoghesi, la quale aveva già trovato una persona che si occupasse delle pulizie dell’appartamento del II piano, decise di provvedere alla preparazione dei pasti e da allora tutti mangiarono insieme. La comunità cresceva. Si aggregò La Pira che per un certo tempo aveva abitato con Dossetti in via Bonifacio VIII – oggi via Alcide De Gasperi – nello stesso palazzo dove abitava lo statista trentino; vennero via via altri giovani. Il nome della Comunità del Porcellino, racconta Tuzi, nacque dall’intercalare che Laura Bianchini – in casa detta Laurona per distinguerla da Laurina Portoghesi, molto più piccola e minuta – era solita utilizzare. “Laurona, carattere forte da “vecchio alpino”, come a lei piaceva definirsi, quando perdeva la pazienza etichettava gli interlocutori, e specialmente i commensali, con l’epiteto: “Tu sei un porco””. L’11 giugno del 1947 alle ore 21, nel salotto bello della casa fu convocata la comunità e nello spirito fucino – sanamente goliardico – che li distingueva, fu redatto un atto ufficiale di costituzione con il padre Caresana in qualità di notaio. Autori principali del testo furono un altro oratoriano: padre Guido Adolfo Martinelli – anch’egli bresciano – e la professoressa Bruna Carazzolo di Padova, a Roma in quanto vicepresidente dei laureati cattolici, e ospite fissa alla tavola della “Comunità”. “Il primo emblema della Comunità fu un porcellino di vetro appeso, con nastro tricolore, al lampadario della sala da pranzo. Dono di Vittorino Veronese. Fu seguito da un tagliere di legno a forma di porco che fu suddiviso in diverse parti assegnandone una a ciascuno dei soci: lardo di Beppe (Lazzati), spalla di Criconia, pancetta di Piccioni, prosciutto in miniatura di Laura (Bianchini), zampino di Fanfani, zampone di Pippo (Dossetti), gota di Angela (Gotelli), cuore di Giorgio (La Pira), grugno di Calosso, orecchie di Portoghesi. “Sul retro fu scritto: Lazzati, Dossetti, Gotelli e Bianchini furono a Roma da porcellini, a eterna memoria di loro pose il Ministro del Lavoro. 1947″. Inutile dire che la routine dei pranzi e delle cene fu movimentatissima e che spesso si distingueva per ospiti molto particolari. Da De Gasperi a Scelba, da Maritain a padre Gemelli. Era consuetudine, non sempre rispettata – osserva con rammarico Tuzi – riportare su un diario avvenimenti e citazioni. Una di queste, egli dice, resta chiara nella memoria: sono gli auguri di padre Caresana alla “Comunità” per l’Epifania del 1949. Il parroco della Chiesa Nuova, originario di Brescia, amico carissimo e confessore di monsignor Giovanni Battista Montini, così scriveva: “Ai parrocchiani di via della Chiesa Nuova 14, ultimo piano! Conforto e attesa del Padre curato e… della patria”. Padre Caresana rimase sempre legato a tutti i membri della “Comunità”. E quando Dossetti decise di farsi sacerdote e scese dal religioso oratoriano per comunicarglielo e per chiedere consiglio egli lo portò dinanzi all’altare dove riposa san Filippo Neri e come ricorda padre Peppino Ferrari, che era presente ; fattolo inginocchiare gli disse di affidarsi al santo romano.
La “comunità del porcellino” – Dove è nata la Costituzione? Forse anche a tavola…
La nascita della Costituzione, negli anni della prima Repubblica Italiana, parte da un piccolo gruppo che si ritrovava nei due appartamenti di proprietà delle sorelle Pia e Laura Portoghesi, al civico numero 14 di via della Chiesa Nuova a Roma. Nel periodo dell’Assemblea Costituente, la prima persona a entrare in questa casa è Laura Bianchini, che prende in affitto una stanza di uno degli appartamenti. Un giorno riceve la visita del democristiano Giuseppe Criconia, che le confessa la difficoltà di avere un punto di ritrovo per i membri del suo partito dove poter discutere di politica. Infatti, ognuno di loro vive in punti differenti della città e gli impegni della Costituente rendono difficile ritrovarsi. Una delle due proprietarie di casa, Laura Portoghesi, propone di affittare il secondo piano del palazzo a Criconia. Quest’ultimo coglie la palla al balzo e nell’appartamento si stabiliscono cinque nuovi coinquilini: Amintore Fanfani, già ministro, Giuseppe Dossetti, vicesegretario della Democrazia cristiana, Giuseppe Lazzati, futuro rettore dell’Università Cattolica, Giuseppe Glisenti e lo stesso Criconia. Laura Portoghesi si offrì per preparare i pasti e da allora tutti condivisero insieme i pasti. Ben presto al gruppo si aggrega anche Giorgio La Pira, futuro sindaco di Firenze. Fu così che si venne a creare la “comunità del porcellino”: una sera, infatti, l’allora vicepresidente delle Acli Vittorino Veronese si presentò con un porcellino farcito, dando così il nome al gruppo. L’atto di fondazione della comunità è ufficialmente celebrato l’11 giugno 1947, con la stesura di un documento ufficiale che sancisce la costituzione del gruppo, firmato dai vari membri. Queste discussioni danno vita a una vera comunità, dove nascono idee e linee di pensiero poi riportate all’interno dell’Assemblea Costituente. Questo gruppo, infatti, darà un grande contributo alla stesura della prima parte della Costituzione, principi poi fondamentali redatti dalla Commissione dei 75. Durante questi pasti e incontri non potevano mancare anche ospiti di lusso: da Moro a Scelba, da Maritain a padre Gemelli. Da ricordare anche la tanto attesa visita negli appartamenti delle sorelle Portoghesi, del Presidente del Consiglio, Alcide De Gasperi del 5 febbraio 1948. «Si può anzi dire che alla Chiesa Nuova presero forma e acquistarono vigore molti dei princìpi fondanti della convivenza della nazione che stava risorgendo, e che furono poi trasfusi nella nostra Carta costituzionale, attraverso il lavoro assiduo e paziente di ciascuno dei membri di quella piccola comunità, e il confronto aperto e leale con chi nell’Assemblea Costituente era portatore di altre idee e altri valori. La memoria di quel gruppo di persone e della loro opera deve essere, per noi oggi e per le generazioni che verranno, occasione di rinnovata e convinta adesione ai princìpi fondamentali della Costituzione, che essi contribuirono a formulare, e che tuttora esprimono, i valori irrinunciabili del nostro popolo» (dal libro “Quando si faceva la Costituzione”, Grazia Tuzi e Telemaco Portoghesi Tuzi, ed. Il Saggiatore, 2010).